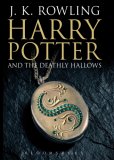
Mi raccomando.

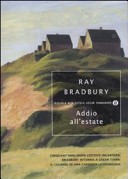
(che ci crediate o no, il video è finito tra le nomination per il premio Hugo 2011, categoria “cortometraggi”)
Comunque, bello, mi è piaciuto e ho capito da dove vengono, credo, parte delle atmosfere e delle visioni di gente come King o Gaiman. Sono ben accetti consigli su cosa leggere di Bradbury ora (credo di aver visto da mio padre Paese d’ottobre, ora che ci penso).
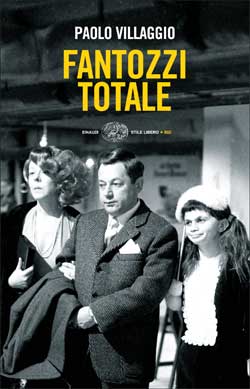
La meravigliosa Liù Bosisio (anche se io per vari motivi preferisco la signora Pina della Vukotic), voce di Marge Simpson (e di Patty e Selma)
I libri di Fantozzi scritti da Paolo Villaggio li avevo in casa tempo fa. Poi ci sono state un po’ di vicissitudini e si sono un po’ sparpagliati. Quando ho visto in libreria il malloppone “Fantozzi Totale” (Einaudi) ho pensato che potevo recuperare immediatamente tutto quanto. In realtà però questa non è una raccolta completa dei primi volumi (i più interessanti, poi Villaggio ha usato il nome Fantozzi per pubblicare altra robetta – un po’ come con i film dopo Super Fantozzi) ma un’antologia che per quanto parecchio ampia si concentra quasi esclusivamente sugli episodi che hanno poi avuto una trasposizione cinematografica, lasciando fuori piccoli quadretti poetici come l’episodio in cui Fantozzi scopre di poter volare o un racconto ferocissimo in cui Fantozzi, mentre al telefono si professa femminista, massacra di botte moglie e figlia. E manca anche il racconto che una volta mi fece rotolare giù dal divano (un ROTFL ante-litteram), in cui una scoreggia è descritta con le parole “rombo di cavallo ungherese”. Ma quello che c’è (a partire da una copertina splendida con la fam. Fantozzi al cenone di Capodanno) è comunque di primissimo livello. Certo, oggi è difficile capire quanto per l’epoca fosse dirompente l’umorismo di Villaggio, quanto fossero precise le sue descrizioni del micro-cosmo lavorativo dell’ufficio e quanto fosse inedita e spericolata la sua lingua fatta di vertiginosi e improvvisi accostamenti di alto e basso, aggettivazione ricercata applicata a eventi minimi, iperboli, climax acrobatici (“mani due spugne, salivazione azzerata, manie di persecuzione, miraggi”; potremmo passare anni ad analizzare il meccanismo comico di questa progressione). Oggi quando vogliamo fare ridere noi (almeno i “noi” che hanno grosso modo la mia età) usiamo un linguaggio che sta tra Fantozzi e la Gialappa’s, ma all’epoca dell’uscita dei primi libri questo genere di linguaggio comico era fuori dalla norma, in Italia. Se li trovate, cercate i vecchi volumi (mi pare fossero Bompiani). Ma se non li trovate, questo campionario della bravura di un autore straordinario in uno dei momenti più luminosi della carriera è un volume da avere.
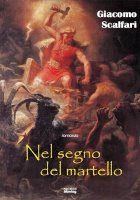
Karlo è un quattordicenne come tanti altri, ama l’heavy metal e ha la passione dei miti nordici. Ma un giorno Thor si manifesta a lui affidandogli una missione fondamentale per la salvezza dell’equilibrio cosmico: deve abbattere l’Anti-Yggdrasill, il pilastro storto dell’universo, e fondare un’organizzazione politica comunista perché Thor, nel caso non lo sapeste, è seguace del socialismo cosmico. Karlo, tra i servi di Loki che vogliono ucciderlo, Roskva e Thjalfi compagni di Thor che lo aiutano e Freda, che gli farà conoscere un altro modo di concepire la vita, si trasferirà a Bologna, città crocevia dei mondi, perché lì il 24 marzo del ’94, durante il comizio elettorale di Fini, si svolgerà l’ultima battaglia.
Questa quarta di copertina è un ottimo lavoro, dal punto di vista commerciale, perché attraverso la scelta delle parole (“missione fondamentale”, “nel caso non lo sapeste”, “socialismo cosmico”; se invece di “Fini” ci fosse stato “Gianfranco Fini” si prendono in un colpo solo i fan di Stanis Larochelle) presenta il libro come un’allegra e spensierata sboronata autoironica, qualcosa che avrebbe potuto scrivere Ammaniti o Morozzi. Visto che in libreria non lo trovavo l’ho ordinato perché, in fondo, la speranza di incappare nella perla sconosciuta uno ce l’ha sempre. E invece. E invece il libro ha una lunga serie di difetti che trovo imperdonabili, a partire dal fatto che si prende terribilmente sul serio. Terribilmente. In Thor che si palesa davanti a un ragazzino italiano in gita nei paesi nordici e gli dice “sono Thor, devi mettere su un gruppo metal e fondare un movimento comunista” non c’è la minima traccia di ironia. E non c’è la minima traccia di ironia nel descrivere l’improbabile infiltrazione di troll tra i frequentatori di un centro sociale e altre scene e vicende che prendono a mazzate ferocissime qualsiasi tentativo di sospensione dell’incredulità da parte del lettore. Se a questo si unisce una narrazione che taglia gli spigoli e non cerca di creare alcuna tensione su sottotrame che avrebbero meritato un po’ più di approfondimento (Karlo deve formare una band? Impara a suonare la batteria in un mese, si unisce a dei suoi amici e il primo concerto è un successo incredibile. Deve fondare un movimento politico? In breve tempo il suo gruppetto conta un sacco di iscritti, e via discorrendo), la voglia di finire in fretta il libro, che per fortuna è breve, è alta. Se non altro ho imparato qualcosina in più sui miti nordici (che Scalfari si è studiato bene) e ho scoperto la storia del Partito Comunista Internazionalista (che ignoravo; ero convinto fossero gli stessi di Lotta Comunista, ma immagino invece che ci siano sottilissime e fondamentalissime divergenze tra le due visioni). Niente, peccato: uno spunto meraviglioso ma un libro che non mi è piaciuto per niente (mi piacerebbe tanto riscriverlo o riutilizzare lo spunto, ma penso che l’autore non sarebbe per niente d’accordo).
 Già che ho citato Morozzi, ad aprile c’è stata la seconda uscita dell’iniziativa di Quintadicopertina a cui sono abbonato: questo ebook si chiama Troppe Storie (per un uomo solo) e tiene fede al titolo presentando anteprime di tre romanzi a cui lo scrittore bolognese (e almeno una redazione di sedici schiavi, come diavolo fa a scrivere così tanto?) sta lavorando, oltre a due racconti. L’iniziativa, ne ho già parlato, è molto bella e se avete un lettore ebook fareste bene a sottoscrivere l’abbonamento; gli estratti presenti sono parecchio divertenti. In particolare, mi ha divertito questo passaggio dalla storia che vede come protagonisti dei fumettari:
Già che ho citato Morozzi, ad aprile c’è stata la seconda uscita dell’iniziativa di Quintadicopertina a cui sono abbonato: questo ebook si chiama Troppe Storie (per un uomo solo) e tiene fede al titolo presentando anteprime di tre romanzi a cui lo scrittore bolognese (e almeno una redazione di sedici schiavi, come diavolo fa a scrivere così tanto?) sta lavorando, oltre a due racconti. L’iniziativa, ne ho già parlato, è molto bella e se avete un lettore ebook fareste bene a sottoscrivere l’abbonamento; gli estratti presenti sono parecchio divertenti. In particolare, mi ha divertito questo passaggio dalla storia che vede come protagonisti dei fumettari:
Ogni tanto, ai pranzi con gli altri autori del giro Gamma, qualche sceneggiatore anziano che aveva scritto Cowboy Jim negli anni sessanta o settanta mi dava dei consigli. “Ricordati” mi diceva, ricacchiando e addentando il pollo “tu tieni sempre una banda di messicani cattivi e armati di fucile dietro una roccia, e un puma in agguato in cima a un albero. Quando non sai come portare avanti la storia, o fai sparare i messicani o fai saltare il puma.”
(immagino sia facile capire cosa sia la casa editrice “gamma” e chi sia “cowboy jim”, se bazzicate i fumetti italiani).
Ma anche la storia londinese promette parecchio bene.
Quintadicopertina ha anche una collana di ebook interattivi (sullo stile dei vecchi libro game), Polistorie, di cui prima o poi devo provare qualcosa.
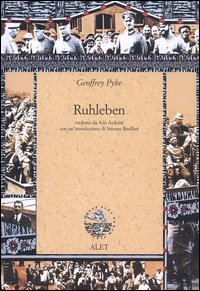
Rivelò quel piano a un giornalista solo molti anni dopo, quando ormai Ruhleben era stata smantellata e lui poteva sentire il bisogno di una piccola vanità: e dunque ecco come andò. Al campo l’appello veniva fatto solo al mattino, dando per scontato che ai tentativi di fuga era necessaria la notte. Ma dopo il tramonto, aveva constatato Pyke, la sorveglianza intorno alle baracche dei prigionieri veniva fatalmente intensificata. La sua inappuntabile strategia finale, la quattordicesima che elaborò, si avvantaggiava del giorno per eludere la sorveglianza, e della notte per affermare la fuga: il fatto è che bisognava evadere con il favore del buio, ma non dalle baracche. In disparte, su un lato del campo, sorgeva un piccolo capanno, usato come deposito degli attrezzi: nel pomeriggio del 9 luglio 1915 Geoffrey Pyke ed Edward Falk si nascosero lì dentro sotto alcune reti (reti da tennis) che non li nascondevano affatto, e rimasero distesi, ad aspettare, con una sufficiente scorta di fiducia. Come ogni pomeriggio, prima che i prigionieri venissero riportati nelle baracche, una delle guardie sarebbe andata a controllare nel capanno. Quando avesse aperto la porta, come ogni pomeriggio di quelle settimane d’estate il sole sarebbe stato ancora abbastanza alto e avrebbe prodotto nel vetro della finestra un riflesso talmente forte da rendere impossibile vedere all’interno, specialmente nella direzione delle reti dove Geoffrey Pyke, immobile di certo e con il respiro in gola, guardò o disse al giornalista di aver guardato negli occhi pieni di sole del soldato tedesco lì in piedi a un metro da lui, prima che come molti altri pomeriggi quello chiudesse la porta dietro di sé e si allontanasse dal capanno senza aver potuto davvero controllare bene. Il resto del piano – scivolare via da lì, raggiungere strisciando la recinzione e superarla – sarebbe stato reso più semplice dal buio e dall’assenza di guardie in quella parte del campo, oltre che da certi esercizi complicati e ridicoli che Geoffrey Pyke diceva essergli stati prescritti per il cuore dal prestigioso, dall’inesistente specialista danese professor Sorgersund e che lo addestrarono invece alle sfibranti contorsioni sotto il filo spinato.
Questo dovrebbe darvi un’idea del personaggio in questione (che ha una pagina fittissima su wikipedia che non ho ancora affrontato), che scrive con un meraviglioso senso dell’umorismo british, così come è squisitamente british il suo understatement di molte situazioni. Però quando vuole sa anche piazzare delle osservazioni precise e puntuali, con una bella prosa.
Alcuni passi:
Una volta uno dei marittimi internati si espresse in modo piuttosto libero sulla natura dei prussiani. Il barone fece il giro del campo e, in ciascuna delle quattordici baracche, infliggendosi numerose e sonore pacche sul petto decorato di medaglie, urlò: «Non siamo noi i sanguinari: non siamo stati noi a volere la guerra a tutti i costi e a provocarla. Non lo accetto: i sanguinari siete voi». In seguito il professore di inglese all’Università di Berlino, anche lui internato, insieme a molti altri, si recò a spiegargli il significato e l’origine della parola inglese «sanguinario».
Come quasi tutti concordano nell’affermare, i tedeschi sono un popolo meraviglioso. Per quella colazione a loro spese non solo mi fornirono pane fatto non con grano, bensì con patate, ma anche caffè fatto non con chicchi di caffè, ma con ghiande. Anzi, tra poco è probabile che inventeranno un surrogato dell’acqua ottenuto da una combinazione alternativa alle solite due parti di idrogeno e una di ossigeno.
A Berlino, la prima cosa da fare è entrare in una birreria; la seconda cosa da fare è entrare in una birreria e la terza cosa da fare è entrare in una birreria. Ma non per bere birra. No. Anche se è leggera come piume su un’ala di colomba, ed è servita così fredda che il vapore della sala affollata fa sgocciolare il bicchiere, tuttavia è meglio bere solo quanto basta a far credere ai vostri vicini che non siete dei bisbetici asociali, che ordinano birra e non la bevono. Invece bevete un sorso qui e ascoltate; un sorso là, e ascoltate ancora; ogni tanto schioccate forte le labbra e scaccerete ogni sospetto eventualmente addensatosi su di voi e verrete considerati dei bevitori moderati, che gustano fino in fondo il proprio bicchiere. Apprenderete anche molte cose interessanti. In Germania ci sono due posti preziosi per raccogliere informazioni: uno è la carrozza ferroviaria e l’altro è la birreria. I soldati chiacchierano sempre per stabilire con precisione chi di loro sia più prossimo all’inferno, e la Germania è composta interamente di soldati.
Leggendolo, la cosa più straniante di tutte è pensare che il narratore non è, come potrebbe sembrare, un distinto gentleman quarantenne ma un ragazzo di ventuno anni. Evidentemente, una volta si cresceva e si maturava parecchio più in fretta.
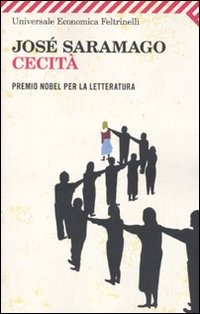
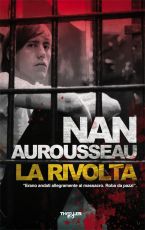
La narrazione è piuttosto frammentata e il tono richiama quello dolente di certo noir francese, comunque, come quello di Izzo o Manchette, che di Aurousseau (che dopo il carcere è diventato un idraulico) è stato lo scopritore.

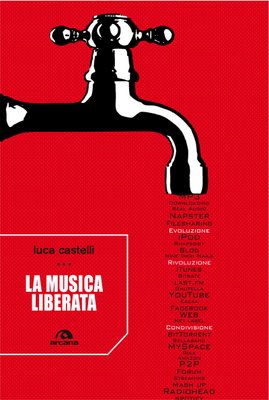
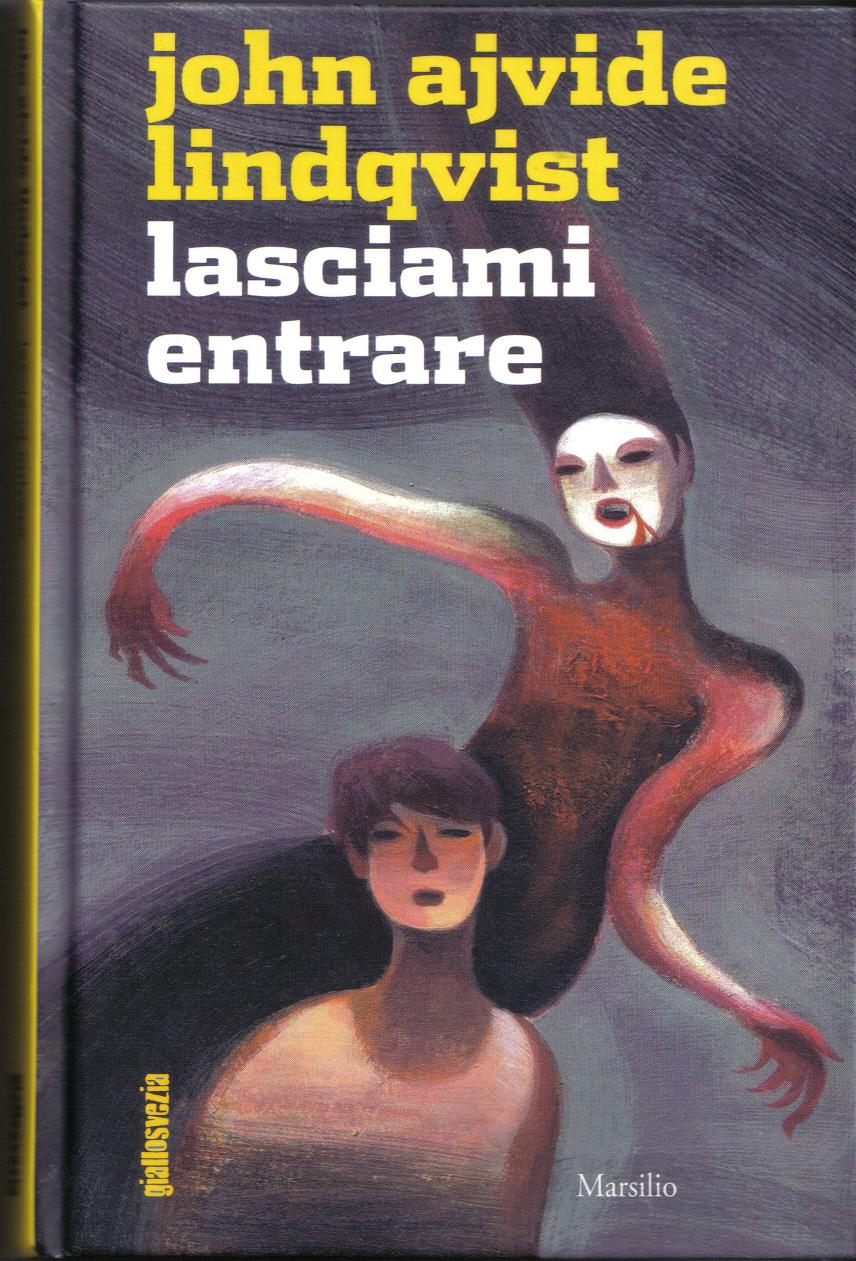

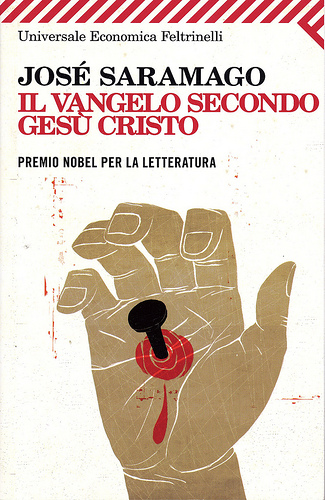







 Colei che canta (Storie dello Spadaccino Vol.2)
Colei che canta (Storie dello Spadaccino Vol.2)





