L’archivio della Stampa permette di fare ricerche su tutte le annate del giornale, dal 1867 a oggi.
Uno strumento potentissimo per fare ricerche su “come eravamo” senza spostarsi da casa per andare in biblioteca. Sono certo che ci sia gente che lo usa per cose altissime e utilissime. A me, invece, è venuto in mente di andare a cercare cosa scriveva il giornale della FIAT degli eroi della musica moderna.
Il primo esperimento è stato succosissimo:

Questa anonima “fotonotizia” del 28 ottobre 1963 è stata evidentemente passata senza sapere bene di che cosa si trattasse, visto che il redattore ha deciso che questi “Beatles” dovevano essere un duo, tipo gli Everly Brothers, visto che nella foto sono in due. Così Harrison non solo è immortalato brancato da una giovane svedese ma diventa persino titolare al 50% dell’impresa.
La seconda menzione dei Beatles in quel di Torino è di sfuggita, in un articolo sulla crisi del cinema inglese del 7 gennaio 1964:
Nel 1953 c’erano in Inghilterra oltre quattromilacinquecento cinematografi. Adesso ne sono rimasti duemila. Tutti gli altri sono stati trasformati in sale da ballo, dove la gioventù inglese impazzisce per i «Beatles», un gruppo orchestrale di quattro urlatori
La terza volta che si parla di Beatles, il 16 gennaio 1964, è con un articolo e una foto tutti per loro:

Di nuovo, nell’articolo, George suo malgrado sale sugli allori:
I «Beatles» sono quattro, tutti di Liverpool, hanno dai 20 ai 23 anni e si chiamano Ringo Starr, John Lennon, George Harrison e Paul Cartney. Il primo suona la batteria, gli altri tre suonano la chitarra. John, che è ammogliato ed ha una figlia, scrive con George le parole e la musica delle canzoni che mandano in estasi le ragazzine britanniche.
In riva al Po dovevano avere un debole per il Beatles schivo, ma dovevano essere anche parecchio spaventati da queste orde di giovani urlanti.
Il primo titolo dedicato ai Rolling Stones è un capolavoro, in questo senso:

È l’agosto del 1964 e nel sottotitolo c’è la parola “soqquadro”. Il resoconto è purissimo rock and roll:
I primi incidenti si sono verificati al termine di un’esibizione dei « Rolling Stones », cinque giovani inglesi che suonano le musiche moderne più vivaci e che appunto al Casinò di Scheveningen avevano raccolto migliaia di fanatici ascoltatori. Che cosa sia successo esattamente non è possibile sapere. La polizia, quando è intervenuta in forze, accorrendo persino dall’Aia, ha avuto il suo da fare a dividere gruppi di ragazzi e ragazze, che si picchiavano o si dedicavano ad atti di vandalismo contro i negozi, gli alberghi e le automobili. Una ragazza è. stata trovata completamente svestita e gli agenti l’hanno ricoperta alla meglio con un impermeabile. Altre due ragazze di sedici e diciassette anni si sono presentate spontaneamente alla polizia, piangendo e sostenendo di essersi trovate spogliate nel mezzo della mischia.
È invece il 19 luglio del 1968 la prima volta che Jimi Hendrix fa capolino sulle pagine della Stampa, in un box di micro-recensioni:

La mia notizia preferita su Hendrix però è quella successiva, su StampaSera del 3 dicembre 1968, intitolata “SACERDOTE FA SEQUESTRARE LA COPERTINA DI UN DISCO”:
Un sacerdote ha visto la copertina in un disco esposta in un elegante negozio della Crocetta, si è scandalizzato e dopo una breve discussione con il commerciante ha telefonato in questura ed ha chiesto l’immediato sequestro della fotografia incriminata che raffigurava donne nude. L’ispettrice di polizia e gli agenti che la accompagnavano erano imbarazzati ed hanno deciso di «ritirare» la copertina. Sulla singolare questione deciderà in giornata la magistratura. La fotografia a colori rappresenta un folto gruppo di donne nude, in una posa che ricorda certi famosi dipinti di Delacroix. E’ la copertina di un disco di musica psichedelica con interprete il capellone inglese Jimi Hendrix. Appartiene alla Casa «Track» e non viene normalmente distribuito in Italia. L’ha comprato, durante una recente visita a Londra, Mario Pecol, che è appunto titolare del negozio di corso De Gasperi n. “7-bis. L’altra mattina un sacerdote ha notato la copertina, è entrato nel negozio ed ha chiesto al Pecol di toglierla immediatamente dalla vista dei passanti. «Ma se va in una qualunque edicola — ha ribattuto il commerciante — trova fotografie molto più scandalose di questa». Il religioso ha insistito, quindi si è rivolto per telefono alla squadra del «Buon costume». Pochi minuti dopo l’ispettrice di polizia Giuliana Cervini era nel negozio in compagnia di due agenti. Era la prima volta che le capitava di dover intervenire per il sequestro di un disco. Si è consultata a lungo con i colleghi, quindi ha ritirato l’oggetto della contestazione rilasciando una ricevuta nella quale si legge che il provvedimento è stato preso «per far fotografare in questura la copertina». In giornata l’ispettrice-capo di polizia, dottoressa Meini, si reca dal procuratore della Repubblica di Torino perché decida se mantenere il sequestro oppure restituire al negoziante la copertina incriminata.

È un quadretto bellissimo con il prete, l’ordine costituito, il negoziante che va a Londra a comprare i dischi che in Italia non si trovano. E mi piace pensare che in questura la fotocopia della copertina sia rimasta appesa in molti armadietti per anni. Purtroppo non ci sono più notizie al proposito.
E gli Who?
Facile. Stampa Sera, 24 agosto 1966, rubrica delle domande dei lettori:
Chitarre infrante
Perché i Beatles si chiamano Beatles?
Elena Delogu, Roma
«Beatle» significa scarabeo. I quattro cantanti hanno scelto per il loro complesso questa denominazione perché nell’abbigliamento e soprattutto nell’acconciatura dei capelli somigliano vagamente a coleotteri. Il mondo della musica leggera anglosassone (e per riflesso anche il nostro che lo imita molto) è pieno di simili stravaganze. In Gran Bretagna accanto ai Beatles sono celebri i Rolling Stones «pietre ohe rotolano», dal proverbio «a rolling stone gathers no moss»; cioè «pietra che rotola non prende muffa», gli «Animals», i «Pretty Things» (= «Cose carine», detto ironicamente, perché son molto brutti) i «Kinks» (= «grilli per la testa» o anche «accessi di tosse»), la chiassosissima «Band of Angels («banda di angeli») e, ultimi arrivati, i «Who» (= «Chi», cioè invece d’un nome han scelto un pronome). I «Who» hanno la caratteristica di spaccare deliberatamente le loro chitarre sulla scena. I «Beatles» al confronto paion musicisti da salotto del ‘700.
Si noti che il redattore sfata la cattiva traduzione “Beatles – scarafaggi” e che sembra essere decisamente sul pezzo per quello che riguarda la musica inglese.
I Beatles sono comunque ancora nel 1970 il perno attorno al quale far ruotare la spiegazione del rock. I Led Zeppelin, per esempio:

Londra, 17 settembre. E’ la fine di un’era: i Beatles hanno ceduto il trono della musica pop al quartetto dei Led Zeppelin. L’avvenimento è stato definito «una rivoluzione pop» dal settimanale «Melody Maker», i cui lettori hanno decretato il tramonto dei lungocriniti ragazzi di Liverpool. Ma, come dopo ogni rivoluzione, è valido anche in questo caso il detto «plus ça changen». Gli Zeppelin sono un complesso rock, nella tradizione dei Beatles. Essi, tuttavia, rappresentano la musica underground, cioè quella del mondo semi-clandestino hippie, più dei Beatles, che da sei anni facevano ormai parte dell’establishment musicale, e sociale, britannico. E’ stata una «rivoluzione nella rivoluzione». Gli Zeppelin hanno conquistato il primo posto tra i complessi inglesi ed internazionali, oltre a quello per il miglior album britannico. Al secondo posto, i Beatles, ormai divisi e in declino. Non hanno giovato loro i miliardi, le onorificenze, le attività cinematografiche, i litigi, il distacco anarchico dalla gioventù britannica in continua evoluzione. John Lennon dipinge e fa il rivoluzionario, Paul McCartney incide dischi per conto suo, George Harrison si occupa di filosofie orientali e Ringo Starr, il meno dotato musicalmente, suona la batteria a casa propria. I Beatles hanno rappresentato per la gioventù meno sofisticata d’Inghilterra ciò che fu il commediografo John Osborne («Ricordo con rabbia») per la classe media degli Anni Cinquanta. La musica, le idee, le evasioni oppiacee dei quattro musicisti hanno effettuato una rivoluzione nei costumi della gioventù britannica. Il mondo dei Beatles, prima romantico, si stemperò nella magia allucinogena di Sergeant Pepper, quindi nella delicatezza formale di Abbey Road, per scivolare nella relativa mediocrità di Let it be. Gli Zeppelin raccolgono l’eredità dei Beatles e portano nuovi valori, sia pure incerti e talvolta eccentrici, della ribellione underground, non solo musicali. Non nasce quella società alternativa che promuovono con le loro attività, ma in compenso si arricchiscono. I Led Zeppelin hanno già guadagnato tre miliardi di lire. I loro nomi forse diventeranno famosi quanto quelli dei loro predecessori. Jimmy Page è il chitarrista, John Bonham è il batterista, John Paul Jones si avvicenda ai vari strumenti e Robert Plant è un ottimo cantante. I loro dischi più famosi sono Whole gotta love e How many more times. Sono ragazzi capaci di sviluppare una musica emotiva con ritmi piacevoli non privi d’un forte swing. Non amano le luci della ribalta, non hanno mai inciso un disco a 45 giri, né sono mai apparsi alla televisione britannica. La loro musica, dicono i fans, fa «partire» chi ascolta, è capace cioè di dare sensazioni simili ad un «viaggio» psichedelico. Anche sul loro conto, tuttavia, già circolano voci di una probabile scissione. Ieri sera gli Zeppelin sono venuti appositamente dalle Hawaii, dov’erano in vacanza, a Londra, per partecipare ai festeggiamenti in loro onore al Savoy Hotel. Robert Plant è stato anche nominato il cantante più popolare della Gran Bretagna. Al ricevimento mancavano i Beatles sconfitti. Dalle loro lussuose dimore di campagna, John, Paul, Ringo e George non hanno commentato la sconfitta. Con gli Zeppelin, tuttavia, non si ripeterà la «beatlemania». I nuovi idoli della musica pop non hanno nuovi messaggi da dire ai giovani inglesi. Venderanno più dischi, ma saranno sempre i Beatles ad avere rappresentato una svolta determinante nella musica pop dei nostri tempi.
L’ho copiato tutto perché comunque è un bel pezzo in diretta dalla fine di un’epoca. Il 24 novembre del 1970, “Led Zeppelin III” figurava come disco da regalare “alla ragazza beat”.
A sorpresa, i Deep Purple appaiono per la prima volta in un box di consigli discografici,il 25 febbraio 1969, così:

E i Black Sabbath? La loro prima citazione è in un articolo del 4 agosto 1970 sui riti satanici (figuriamoci):
Le mode girano. La stregoneria è ormai l’ultimo grido della generazione pop e i « figli dei fiori » stanno cedendo il passo ai «figli di Satana». Un avido commercialismo già sfrutta la nuova voga demenziale: gli opuscoli sulle pratiche occulte e le ristampe dei vecchi trattati di magia nera si moltiplicano; l’arte informale volge al «prisma magico» (proprio a Roma un pittore esperto in astrologia e geomanzia ha tenuto una mostra) e abbiamo i dischi della dannazione ritmica, abbiamo i complessini musicali, come Black Sabbath e Black Widow (inglesi, naturalmente: da dove, se non dalla Gran Bretagna può partire l’offensiva degli spettri?), specializzati in «messe nere» sceniche e così via.
C’è anche il resoconto di un travagliato festival palermitano del 1971 in cui i nostri hanno diviso il palco con, tra gli altri, Bobby Solo, nel settembre del 1971:
Assenti i Circus 2000, assenti i Mungo Jerry, rinunciatari gli Osanna per non essere stata accolta la loro richiesta di esperti addetti alle luci, mentre dal canto loro i Black Sabbath facevano le bizze perché pretendevano di giungere alla Favorita in «Rolls Royce». In queste condizioni, Joe Napoli si è visto costretto a ripresentare Claudio Rocchi, i «Delirium» e Bobby Solo, i quali si erano già esibiti nella seconda serata. Le esecuzioni dei «Delirium» e dei «Black Sabbath » hanno salvato lo spettacolo dal grigiore, ma la loro esibizione ha avuto come risvolto un’ondata incontenibile di entusiasmo. Le transenne sono siate abbattute e il palcoscenico è stato invaso dal pubblico.
(continua? Continuerà?)




















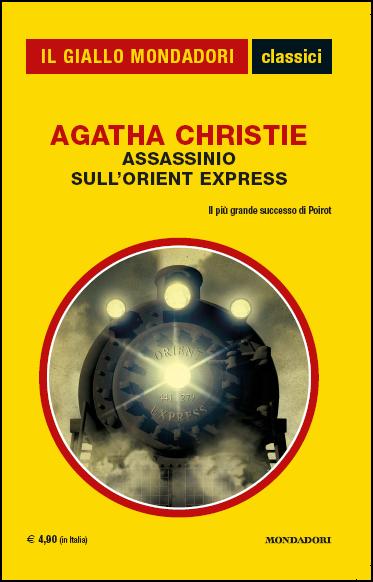

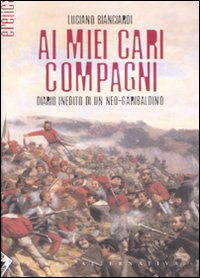
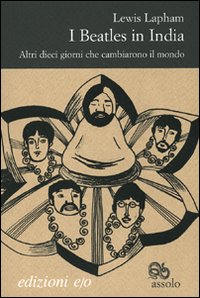









 Colei che canta (Storie dello Spadaccino Vol.2)
Colei che canta (Storie dello Spadaccino Vol.2)





